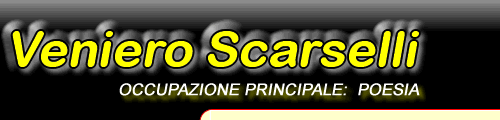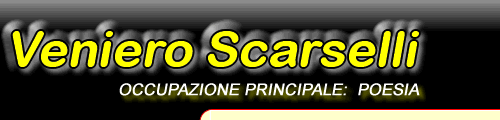TORBIDI AMOROSI LABIRINTI
La prima edizione di Torbidi amorosi labirinti, è uscita nel 1991 con un’introduzione di Luigi Baldacci e per i tipi della Nuova Compagnia Editrice di Forlì. Questa edizione è stata completamente rifatta.
Questa storia d’amore e morte, non priva d’intenti moralistici (delitto e castigo), non è solo il racconto liberatorio di un maschio pentito che ha spinto lo sguardo impietoso sui segreti delle camere da letto e sulle estreme conseguenze della cosiddetta liberazione sessuale; e neanche puro esibizionismo di archetipi dell’immaginario erotico maschile, legittimato da un’evoluzione di milioni di anni, che tuttavia una cultura indulgente al femminismo tende ancora a ridicolizzare; è anche l’anelito dell’uomo a trascendere con la ragione le miserie dei suoi rigidi (perché innati) schemi sessuali e relazionali per attingere il mitico, irraggiungibile, Amore Universale: l’utopia dell’illimitata forza della ragione, strenuamente perseguita e difesa in una battaglia con se stesso che l’uomo tuttavia è incapace di vincere.
Un giorno di limpida estate
mi lasciavo portare dal vento
verso un'isola soave di Sirene
galleggiando su un’onda di fortuna
come un sughero fiorito di meraviglia
fra mille rutilanti seduzioni
e mille deliziose erezioni.
Quel vento di languori e di vaghezze
incalzava prepotente il mio sesso
di giovane ardente coccodrillo
ignaro delle cose del mondo,
ma maturo d’una voglia d’amare
così a lungo dai preti conculcata
e ricacciata nel sangue in tumulto
da sembrare alla luce del sole
quasi dimenticata e sotterrata;
ma ora il vulcano scoperchiato,
s’apprestava ad eruttare fuoco e lava
e a ricoprire il mondo di lapilli.
Correvo finalmente senza ceppi
sulle creste spumose delle onde
come vela impaziente di sfidare
gli incantamenti di Colonne d’Ercole,
volavo alle terre promesse
fra le lusinghe impudiche dei canti
di Sirene dalla fosca bellezza,
che agli erranti cavalieri assetati
dispensavano le grazie più gelose
del loro femminino splendore
rorido di miele velenoso.
M’ero fatto tutto occhi e sensi
ingordamente abbandonandomi all’attesa
degli eventi portentosi che premevano
per sbocciare in quel fiore carnale
cui sentivo ormai sciaguratamente
d’esser tratto da fili invisibili.
L’evento atteso, fulmineo, prodigioso,
fu il furore rapinoso di due occhi
così lascivamente uterini
da sbarrarmi prepotenti il passo
immensi come il mare ed il cielo;
essi furono il fiore ed il frutto
che subito avidamente mangiai
timoroso e voglioso di peccare
e lasciarmi trafiggere di spada
per morire infine d’amore.
Fu così che rapinarono di me
la forza e la ragione ma annientarono
l’omuncolo che ancora languiva
nell’onirico torpore del corpo,
e rinacqui con un’anima vera
di uomo consapevole e infelice.
E' il tributo millenario che la Femmina
infligge alle vite degli uomini;
ogni volta rinasce dalle ceneri
ed ogni volta è inutile dibattersi:
s’insinua senza ostacoli né gemiti
nei recessi più profondi dei visceri,
t’inocula il dolce veleno
che scatena tempeste nell’anima
e poi più imperiosa d’un dio
si erge nell’occhio del ciclone
assoluta signora del tuo io.
Ma a me ch’ero ignaro della vita
pareva un benigno incantesimo,
un dolce peso da portare gioiosamente
come quello del ventre d’una madre
fecondato da un subbuglio luminoso
di cellule neonate; la mia anima
fino allora paralitica e inutile
straripava col fiume della vita
nell’estasi d'ineffabili meraviglie;
e allora con le lacrime agli occhi
correvo per boschi e colline
come un gatto stregato dalla luna
a liberare in teneri sospiri
il delirio che infocava l’universo.
Così non riconobbi il mio destino
quand’esso era appena impigliato
nella rete d’insidiosi batticuori
d’un amore forse ancora acerbo,
ma neppure quando poi con fragore
sboccò alla luce ubriaca della foce
in una piena senz’argini e dighe
che trascinava in mare città e boschi.
Eppure errando per le spiagge senza tempo
dell’amore, abbandonate dalla ragione,
riconoscevo trepidante ovunque
nello sguardo stellato della femmina
che lancinava la mia mente e la mia carne
gli occhi tondi, innocenti, stupiti,
che passo passo mi seguivano, della Morte.
Mi si paravano innanzi ad ogni istante
luccicanti di pianto, ma poi
come cani m’inseguivano e addentavano,
s’impossessavano di me per succhiarmi
la linfa da ogni muscolo d’amore
per ridurmi voluttuosamente
alla loro mercé e volontà.
Ero il naufrago che si lascia scivolare
esausto in un mare primordiale
pullulante di organismi ambigui
che con le loro suadenze lo attirano
nel profondo di mondi sommersi
ed in tane mortali lo nutrono
di dolci velenosissime spezie.
Ella certo un giorno apparteneva
ai mondi maestosi delle selve
più profonde e impenetrate appena emerse
dai vapori e dai silenzi del mondo;
solo un nobile dio delle acque
nascosto nelle antiche sorgenti
la poté generare da una cellula
del suo seme ed ella quando nacque
fu la tormentosamente bella
farfalla imprigionata dal suo dio
fra le paludi delle selve arcaiche
alla penombra di pigri ed afosi
languidi meriggi di fauni,
stordita dal lucore tenebroso
di fieri maschi corruschi di armi
e splendide amorose livree.
Ma era lei, che infine catturava
i loro corpi infelici di libellule,
ne strappava una ad una le ali
e ne faceva sfuggire dai peni
in un sospiro le anime rattrappite
non più capaci ormai di volare.
Ed ora quella dea prorompeva
dai mondi delle selve e delle acque,
dalle quieti di grotte muscose,
alle agresti distese solari
in uno scoppio di messi e di papaveri
per scendere umilmente a donarmi
il suo florido amore terreno
plasmato nella creta primigenia
del suo grembo ed abitato dai sacri
e terribili spiriti della vita;
offriva in sacrificio il mio corpo
alle forze incontinenti della terra
e lui maturo si spaccava come un seme
quando lei lasciva come ape
suggeva la linfa dei baci,
lei stessa forse ignorando
ch’era attratta dal miele della Morte.
Io stesso non sapevo ancora
d’avere perduto per sempre
il piccolo microcosmo del mio io,
l’identità che mi faceva maschio
capace di difendersi e forse
arditamente aggredire ed anche uccidere;
adesso non ero che un nano
accecato dalla foia del suo sesso
in una nera foresta di copule
fra altre libidinose creature,
un rospo abbrancato a un altro rospo
e intento furiosamente a propagare
la sua inutile specie maligna,
totalmente dimentico di anima,
ideali, dottrine, religioni,
ricoperte dalle ceneri della ragione.
Il nostro amore fu creatura di mostri,
non il nobile giusto connubio
di fieri maschi e oneste femmine antico
come il mondo, pedine di un disegno
imperscrutabilmente divino
che si consuma fra uteri semoventi
arrancanti sulla faccia della terra
e forti peni alla ricerca di tane
per congiungere geni preziosi
e generare il buon frutto della specie.
Fu solo una furia animalesca
così perversa da renderci schiavi
e costringerci a portare fino a morte
il peso infame della nostra opera
quasi fosse una creatura maligna
aggrappata saldamente ai capezzoli
e succhiasse depravata con i denti
il latte della nostra triste poppa.
Più nulla è capace d’arrestare
le anime degli esseri infelici
che ghermite dalla ruota inflessibile
degli astri si scontrano nel cielo
per fatale attrazione e in un bagliore
si consumano in miriadi di stelle
che ricadono spente sulla terra.
Così, bruciata ogni speranza di salvezza,
rotti i ponti col mondo degli umani,
ai rassegnati colpevoli non resta
che abbandonarsi in golose caverne
al divorante peccato di un amore
da cui sanno che non v’è più ritorno.
Ella allora a piene mani, voluttuosamente,
in un urlo lussurioso del Creato
mi donò tutte le perle e le delizie
dei frutti più maturi e sapienti
d’una turgida carne doviziosa
non ancora corrotta dal Demonio;
mi uccideva d’amore con le grida
di orgasmi mai uditi che salivano
fino al cielo e mi lasciavano inchiodato
nella morsa ferina delle cosce
a perire nel risucchio famelico
di quel potente imbuto della vita,
pauroso signore e tritacarne
il cui unico fine è rubare
il nobile seme degli uomini
per dare un inutile alito
a copie ingloriose di noi stessi,
tristi e avidi feti neghittosi
da disperdere invano per il mondo.
Quella cieca funzione animalesca
era il pendolo e la ruota del mondo,
la sapienza del Motore Immobile
i cui potenti ingranaggi macinavano
nel suo ventre profondo e imperscrutabile
il pene incauto d’un povero maschio
con tutti i pensieri e le ossa
private di memoria e di coscienza;
l’accecante splendore uterino
era il Sole che si autodivora,
il furore del magma originario,
il crogiuolo collettivo dell’Essere,
colui che crea gli individui e li distrugge,
colui che salva e uccide,
colui che in sé contiene il Bene e il Male.
Per quanto tempo ella colse dal mio organo
i frutti più sapidi e vermigli
ingozzandosi con furia golosa
per rimpinzare il suo ventre mai sazio?
Non so dire neppure se vissi
o non vissi, in quel crepuscolo mortale
di veglia allucinata, o non-veglia,
dove il vero signore e padrone,
il fantasma del giorno e della notte,
era solo quel sacro orifizio
nel cui fondo buio e misterioso
ero ossessivamente costretto
a penetrare col sordo furore
espropriatorio d’uno schiavo ribelle
e il desiderio sacrilego d’ucciderlo,
ma solo per farlo rinascere
come araba Fenice immortale:
tenebrosa sorgente rigeneratrice
cui prendere la vita per vivere
e farla dalle ceneri rivivere.
Durò mesi, secoli, o giorni,
sottratti al quieto flusso dell’universo,
la rapina d’anima e sangue,
il continuo strapparmi la vita
a brani come carne salvifica
per cibarsene senza ch’io potessi
mai carpirle dal ventre il segreto
del suo eterno morire e risorgere?
Ogni volta ingoiava il mio seme
e digeriva sacrilega le cellule
per fornire energia alla sua macchina,
m’avvinghiava e succhiava come un polpo
che spreme il suo eterno nemico;
e io ero la vittima incauta
scivolata nella tana del predone.
Fu questa la mia vita vegetale
di verme destinato da Dio
ai disegni più tirannici del sesso,
che ignoravo scaturissero dall’arca
primordiale della specie; ero la talpa
che insegue una luce irraggiungibile,
mi gettavo nei meandri dei suoi visceri
coi fremiti convulsi del mio organo
che si univano e intrecciavano ai suoi
in un viluppo di bocche inappagate,
ed infine spremevo in un fiotto
il tributo di cibo necessario
alle arcane sue avide digestioni.
Finché un giorno funesto mi destai
nel bel mezzo d’un pasto tribale.
Ero assolutamente sazio
del suo avido ripugnante cunicolo.
Mi pareva addirittura un sogno
che in quella tana si fossero intrecciati
fino a ieri in un delirio di libidine
la mia anima e il suo viscido sesso
cercando disperatamente l’estasi;
per un perfido maleficio,
i miei lombi, i precordi, il midollo,
le più nobili radici del pene,
non provavano il più piccolo morso
di emozione per quel tristo budello.
Era forse un’automatica difesa,
una crudele vendetta dei sensi
sfiniti dallo sforzo temerario
di scalare la fortezza della femmina
e possederne finalmente il sacello;
e allora riconobbi il vero mostro
contro cui aveva osato cimentarsi
il Cavaliere dalla Triste Figura
nella foga petulante ed inane
di sconfiggere i mulini a vento.
Ma forse era solo uno strappo
ai fili sottilissimi dell’anima,
pur ben custodita nella scatola
del mio inconscio ma ferita dagli oggetti
contundenti della vita quotidiana;
oppure un’incresciosa infiammazione
dei nervi addetti a sostenere nel bisogno
il goffo pene in questo corpo animalesco;
forse il pene, che credevo bello e forte,
aveva vele troppo delicate
per solcare gli oceani turbolenti
della grande potente Vagina.
Ogni causa, insomma, la più incerta,
era buona purché si trovassero
gli infami colpevoli della disfatta,
si potesse nascondere l’onta
ed il timore d’essere scacciato
come un cane dalla tana tanto amata,
allontanare l’orrore del Nulla,
del suo abbraccio senz’appello né perdono.
Il vulcano per un fato sconosciuto,
s’era spento con un umile gemito;
tacevano i cannoni degli assalti,
le trombe delle orgasmiche vittorie;
ora la nobile Vagina
sembrava un’arcigna voragine,
il mostro di cui tutti i Saggi
ci avevano ammonito: stava lì
ancora oscenamente spalancata
fra le macerie fumanti della libidine
e il bruciore dell’onta, era l’orrore
fascinoso e insostenibile del vuoto
che ammalia da gettarvisi per morire.
Era l’ingannevole incantesimo
delle ambigue Sirene di Ulisse
in agguato negli abissi oceanici,
dal cui canto fatale i priapi incauti
sono attratti e poi sospinti dal vento
ad arenarsi mortalmente sulle spiagge
come sgonfie carcasse di balene
incapaci di riprendere il mare.
Ormai non potevo accarezzare
nient’altro che il nostalgico ricordo
di quando il Priapo fiero e statuario
si stagliava contro il cielo per sfidarlo
e suonava e vibrava col clangore
d’una sana campana di bronzo
ai colpetti compiaciuti della mano,
e poi si chinava a specchiarsi
bello ed ignudo come un dio
sulla propria immagine eretta
distesa mollemente ad attendere
il suo premio sul sofà delle Muse.
Ora invece covava il suo morbo
con il cuore spezzato d’una madre
che contempla il dolce figlio handicappato.
Avrei voluto starmene nascosto
a covare il mio torpido male,
curarmi le ferite dell’anima,
leccarle con amore e pazienza;
oppure che il mondo sprofondasse
e fuggire via per i mari
con tutte le vele spiegate
verso un’isola remota e sconosciuta.
Invece rimasi imprigionato
senza scampo nella trappola dell’onta,
con lo sguardo perduto a fissare
i contorni fierissimi e sprezzanti
della vulva tumefatta dalle brame
e accesa come un faro nella notte,
che pareva sbudellarmi con l’occhio
tagliente d’una madre inquisitrice
per scoprire il cancro del mio male
e additarlo al giudizio di Dio.
Passavo le mie ore a contemplare
la superba bellezza carnivora
della strana regina sul suo trono,
le sue vivide labbra luccicanti,
la voragine socchiusa dall’imene
che evocava tenebrosi misteri,
e al di sopra l’imperiosa clitoride
a guardia dell’abisso; osavo anche
avvicinarmi quasi voglioso
scostando con mano leggera
ogni petalo della grassa orchidea,
la gran nemica in cui ficcare ancora
almeno gli occhi, il naso, la bocca,
ma mi feriva il suo sguardo insostenibile
che si sporgeva aguzzo sul mio viso
per ingoiarlo nel buio senza fondo
del suo ventre rapace senza stelle.
Perché non fuggii prontamente
dalle calde scivolose braccia
che celavano, così irresistibilmente
travestito, il pungiglione terribile?
perché indugiai, debolmente dibattendomi
nella tela vischiosa di quel ragno
fra angosciosi sentimenti di colpa
ed inutili dubbiosi ragionamenti?
L’ingranaggio dentato della vulva
forse ancora m’avrebbe risparmiato;
invece m’inchiodò alla mia croce
di debole montone sfiatato
per succhiarmi il poco seme dal midollo
e lasciarmi come un sacco raggrinzito,
una spoglia pietosa di tetrapode
crudelmente svuotata d’ogni organo
e incapace di difendere l’onore.
Fu sempre più raro e dispendioso
saziare quella bocca di Infanta
col timido capezzolo del mio organo
ignaro dei mali dell’anima
e così riluttante a nutrirla,
costretto con puntelli elaborati,
manovre astute e gran consumo di risorse,
a sopperire almeno manualmente
alle funzioni che venivano meno.
Mai avvenne d’altra parte che ella
dall’alto del suo podio superbo
tentasse di curare almeno l’anima
sgomenta ed ammalata del meschino
dando spazio a più nobili passatempi
che gettassero un ponte levatoio
fra il lugubre portale del suo sesso
e il poveretto, una parola amica,
almeno un grido generoso dai merli
così alti e inaccessibili del castello.
Talvolta circuiva il mio sesso
con astute scenografie sentimentali
e tutti i più pietosi soccorsi
ove più non soccorreva il sex appeal
d’una umana gentile bellezza;
oppure infieriva con concrete
impudiche stimolazioni meccaniche
che uccidevano il timido ego
del mio membro già troppo infelice;
lo mungeva con rabbiosa determinazione,
come s’usa per le vacche riottose,
allo scopo d’ottenere finalmente
il suo piccolo pasto, che sapeva
appartenerle per diritto di natura.
Fu così che rimasi intrappolato
nel suo angusto mondo primordiale
di uteri, orgasmi, fecondazioni,
dove i geni più eletti della specie
avevano abdicato alla salvezza
e languivano nel sonno della ragione.
Dovetti consumare fino al fondo,
prigioniero d’una grigia routine,
lo straziante esaurimento della lussuria,
discendere una china inarrestabile
di turpi alibi, fantasmi di erezioni,
godimenti penosamente artefatti,
inseguito dal suo sordo, accusatorio,
rotolarsi insoddisfatta nel letto
con mugolii di lupa ferita.
Osceno come un despota deposto,
il mio piccolo pene giallo e sgonfio
pendeva impaurito nascondendosi
mentre intorno il suo impero franava
abbattuto dalle orde dei barbari.
Ma un giorno ch’ero chino sotto il giogo
e cercavo un pensiero di salvezza
o almeno una finestra sul mondo
m’accorsi che la mente fuggiva,
indugiava a giocare con dei frustoli
di immagini pazzamente stimolanti
sbucate come serpi da non so
quale pozzo inesplorato della memoria.
Fui lesto ad aggrapparmi a quell’ancora,
che allora non mi parve affatto turpe,
dando libero corso a fantasie
le più voluttuosamente lascive,
ed ottenni anche effetti insperati
nel ridare temporanei vigori
al vecchio priapo caduto in disgrazia;
riuscii perfino a tradire bellamente
la furba lupa eiaculando a dovere
nella sua pur sbiadita vagina
con la foga d’un pene fedelissimo,
mentre invece stavo fornicando
con ben altri impudichi fantasmi,
altre grasse e molto più eccitanti
vaginiformi protesi mentali.
Tutti i predestinati all’inferno
coltivano in fondo alla mente
buie tane traboccanti di serpi;
se si nominano alla luce del sole
esse subito fuggono d’ogni parte
ma subito d’ogni parte ritornano
in un maligno brulichio di tentazioni
inconfessabili; ebbene, appresi l’arte
di allettarle, lusingarle, intrattenerle,
masturbarle nella mente ad una ad una
finché schizzavano un magnifico veleno
che dava fuoco a quel pene miserabile
scendendo nei precordi e gonfiandolo
ancora come quello del dio Priapo.
Finalmente con un brivido soave
potevo riudire il dolce suono
della verga tesa fino a spezzarsi,
il fremente vibrare dell’acciaio
sotto il tocco deliziato delle dita
che ne traevano musiche di arpa.
Imparai anche a confessare
alla mia donna i veleni inconfessabili
che affollavano la mente propinandoli
dolcemente col soffio dell’alito
e il favore crepuscolare del talamo
nel gran buco accogliente del suo orecchio,
e poi sempre più audacemente
dando loro l’aspetto di scaltri
impudichi fantasmi che suadenti
s’insinuavano fra noi con lussurie
sofisticate ma sempre più pressanti,
finché al primo segno di deliquio
snudavano davanti ai suoi occhi
in un urlo di libidine il trionfo
delle turgide clave, ed io gridavo
negli orecchi in delirio dei suoi visceri
incitandola a insaziabili penetrazioni
e scatenando un’eruzione interminabile
di rantoli, di magma, di lava..
Da allora col potente e terribile
strumento immaginifico della lussuria
inoculai in quella semplice mente
già infetta dal peccato di Eva
le più fantasmagoriche droghe;
m’abbandonai sfrenatamente ad ideare
sempre nuove lascive violazioni
di tutti i suoi recessi più gelosi,
soffocavo di piacere i suoi sensi
con sempre nuove fantasie di membri
superdotati che nel buio galeotto
con le proboscidi accese di libidine
tutti insieme la frugavano fra le cosce
per unire i loro fremiti convulsi
ai suoi in un’orgia di api lussuriose;
con la saliva velenosa del rettile
gettavo a quella belva in calore
ogni nuova eccitante invenzione,
fino al raptus supremo e terribile
in cui l’anima colava incandescente
svuotandomi la sacca del sesso.
Ero il sapiente Maestro
che delle proprie creazioni compiacendosi
plasmava la materia dei sensi
con le agili dita della mente;
io ormai non fornicavo più
con il grigio sesso peloso
d’una semplice femmina mortale;
io solo immortali creature
facevo magicamente apparire
nel suo rozzo corpo animalesco
che ronzava cupamente come un’arnia;
io solo incantevoli dee
andavo cavalcando fra le sue cosce
accese dal mio ardente furore,
nobili baccanti dell’Olimpo
tutte prone a ricevere il miele
dalla splendida potente mia daga;
che ora finalmente incuteva
venerazione, come quella nobilissima
di lucido acciaio dei re.
Ella mi divenne soltanto
un duttile strumento nelle mani,
un comodo divano su cui stendermi
intento a godimenti esclusivi
e su cui psichedeliche musiche
accendevo soltanto per gustare
le sfrenate mie danze mentali.
Io ero il sovrano e regnai
sui suoi docili sensi ammaestrati
con le morbide arti e col pugno
del fanatico direttore d’orchestra
guidandoli all’unica foce
del piacere ed orgoglio virile;
lei pendeva dalla mia bacchetta
con la bocca assetata di baci
per strapparmi il finale esaltante
della grande cavalcata delle Walchirie.
Ma la mia era bocca mostruosa
da cui lei pendeva come infante
che succhia da una poppa doviziosa
menzognere mortifere secrezioni.
Purtroppo l’apparato di finzioni
che intrigava e agitava i nostri organi
così armoniosamente accordati
troppo presto finiva crollando
come un fragile palazzo di vetro
non appena il delirio aveva fine
e le scie iridescenti di stelle
schizzate dai meandri della mente
diventavano polvere grigia,
triste pane e vino quotidiano.
Ben presto riconobbi l’orror vacui
che m’aveva intrappolato il triste membro
già una volta fra i nodi dell’anima;
m’assaliva di nuovo la paura
di perdere con lui l’unico tramite
col mondo, il mio diritto all’esistenza,
la naturale cittadinanza della specie,
di smarrirmi per sempre nello spazio
come astronauta abbandonato dalla nave.
Ancora dunque all’infelice vulcano
accadde di spegnersi in un gemito;
tacquero di nuovo i mugolii
ed i ruggiti, le grida degli assalti
e le nobili convulsioni del pene,
le visioni, le estasi, le trasfigurazioni.
Da eroe e maestro
divenni schiavo del mio triste sesso,
venni ancora posseduto dall’ansia
di rianimare, riscaldare, dar sollievo
al pene morto e freddo che pendeva
come un pesce sul banco del mercato
con gli occhi vitrei e acquosi ormai dimentichi
delle grandi esaltanti emozioni,
di quando con le vele al vento
sapeva ben varcare con onore
gli abissi insidiosi degli oceani
al timone di regali vagine.
Sognavo di oceani e di deserti,
di isole perdute e di montagne
dove il mio rovello avesse fine
e da me non venisse preteso
nient’altro che ammirare dalla vetta
con l’amore puro dell’anima
le grandi meraviglie del Creato,
e poi gettarmi bagnato di lacrime
dalla rupe in uno slancio di dolcezza
verso il sole come Icaro sfortunato.
Continuavo a cercare la salvezza
che Iddio e la Natura matrigna
negavano al mio sesso neghittoso
invocando solo astri impassibili
e una fortuna che m’aveva abbandonato.
Ero l’infelice sconfitto
dalla forza animalesca della vita
che irrompeva nel mondo con la furia
e i bisogni imperiosi d’una femmina
ch’era solo lo specchio fedele
di tutte le mie brame più viziose;
ella m’incalzava col suo fiato
fin nei sogni sempre più annichilendo
questo pene senza peso né sostanza
confinato solo ai piccoli piaceri
senza gloria di funzioni emuntorie.
Dovevo assolutamente liberarlo
dalla trappola dorata dei suoi stessi
ingannevoli intrighi, salvarlo
dai luoghi della sterile astrazione,
dunque uscire alla luce, avvicinare
fratelli senza nome, viziosi
miei pari, implorare il soccorso
dei loro incrollabili peni
dai perfetti ingranaggi automatici.
Da allora mi trovai sempre più spesso
a pensare a quei veri e reali
esseri umani di carne
della stessa mia specie dannata
ma senza volto, anzi vuoti come involucri
di pelle grigia fors’anche un po’ bestiale,
come quelli che s’incontrano nei tram,
nelle balere o sui giornali dell’eros,
con sembianze quasi innocue ma che sotto
hanno priapi potenti di cane
e grasse vulve di cagna in calore.
Presi dunque ad uscire con cautela
dalle plaghe solitarie del mio eros
battendo ogni strada e ogni tana
col passo furtivo del felino
che sceglie con pazienza le sue prede
fra quelle più colpite dal vizio,
i suoi strumenti di piacere fra i topi
usi abbandonarsi nelle chiaviche
ai culti più esoterici della trasgressione.
Le mie prime esplorazioni di segugio
scoprirono un ghiotto sottobosco
di torbide anime nascoste
in buie catacombe dove il sole
era mai penetrato a stanare
i serpenti di Sodoma e Gomorra;
dovetti sostenere gli sguardi
sospettosi di peni superdotati
e di vulve tenebrose dagli occhi
dilatati da appetiti sconfinati,
agitantisi in gironi dell’Inferno
in cui regnava l’orrore della noia;
erano dunque dei fratelli,
e come me trascinavano le vite
di senzadio con le impronte indelebili
d’una folle insoddisfatta lussuria.
Fino allora avevo allattato
le mie deliranti erezioni
soltanto col latte mentale
di fantasie nel segreto d’un talamo
e d’una sposa in fondo a me cara;
quindi non fu senza fatica
né spietato lavorio analitico
che il progetto appena partorito
poté abbandonare le mollezze
delle innocue fantasie d’alcova
per dei lidi più reali e perigliosi;
dovetti almeno render presentabili
a me stesso le mie proprie vergogne
travestendole con l’abito lucido
della pura ragione teoretica,
prima di calcare il terreno
emozionante della sperimentazione
con persone vere e reali,
l’ardita e temeraria vivisezione
di esemplari devianti appartenenti
alla gente ipogea dei lucifughi,
che coltivano le larve del peccato
nelle oscure catacombe del sesso
con priapi immuni da difetti e debolezze.
Le mie dotte e ispirate argomentazioni
s’imposero subito alla mia donna
col peso indiscusso della Ragione;
grazie ad essa fui ancora (oh mia allora
così docile compagna!) il suo maestro,
e rapito dal mio ruolo di creatore
dettai fin nei minimi dettagli
le formule di un Eros raffinato,
un catalogo specialistico di piaceri,
le condizioni e le esatte procedure
per squisite lussurie di gruppo;
disegnai il più perfetto meccanismo
fra i sistemi filosofici, la summa
dell’umana sapienza fornicatoria;
ed infine per l’imperio concessomi
dalla Ragione statuii con ardore
anche l’Etica vera e assoluta,
i princìpi ultimi ed eterni
che informano i diritti e i doveri
d’una sana, leale, edificante
gioiosa comunione dei sessi.
Il mio mistico anelito
non vagheggiava surrogati d’amore
ma creava una forma novissima
e sublime di sesso speculativo:
insegnare al mondo degli umili
il piacere mentale di cogliere
i frutti gelosamente nascosti
alla luce invereconda del sole
da mutande e cilici per offrirli
ignudi al sacrifizio della violazione,
agli sguardi sapienti e taglienti
d’una élite che cavallerescamente
ne deliba per giungere al premio
più ghiotto, l’inebriante penetrazione
dell’anima più che del corpo,
ch’è l’unione più vera e profonda.
Il vero e supremo trionfo
era aprire con la chiave del sesso
l’involucro dell’ego, liberarlo
dalla tetra prigione in cui è chiuso,
abbandonare il tubero carnoso
del corpo destinato alla morte
e amare, amare, unire l’anima pura
con quella dei fratelli redenti.
Era dunque, e qui ancora lo grido
invocando a testimoni gli dei,
solo il nobile desiderio d’abbattere
gli ostacoli corporali fra gli uomini
penetrando con l’Io nei loro Io
per il magico pertugio del sesso;
non si sarebbe mai più perpetuato
di figlio in figlio l’antico veleno
dell’ansioso possesso sull’amata,
la gelosia, l’odio, la guerra,
il sangue fratricida; l’individuo
abbandonava il proprio guscio disperato
per farsi ape, cellula altruistica
di un popolo buono ed eletto;
e infine sarebbe crollata
la misteriosa antinomia di maschio e femmina
che da sempre son murati da Dio
in due menti condannate a non comprendersi
ma che da sempre tentano coi mezzi
inadeguati delle bocche genitali
di disperatamente congiungersi
per infondersi l’un l’altro la speranza
di formare un’unica anima
e un’unica carne immortali
benedetti dall’amore di Dio.
Era dunque la vetta più alta
che potesse mai essere scalata
da chi, caduti gli ultimi ostacoli
che separano le anime degli uomini,
spera attingere, anche se blasfemo,
l’evangelico amore universale.
La mia compagna in estasi ascoltava
la mistica dottrina che fluiva
travolgente dalle mie elucubrazioni.
Avevo sezionato e catalogato
tutti i casi teoricamente possibili,
i sentimenti ed i controsentimenti,
i veleni ed i controveleni,
e stabilito patti chiari ed onesti:
la vera liberazione dell’Ego
dalle rigide scorze del suo involucro
doveva farsi alla luce del sole,
tutti avevano il diritto sacrosanto
di contemplare il mistero dei sessi
nella loro epidermica nudità
come s’usa tra i bambini raffinati
quando giocano ai dottori, sfogliarne
tutti i petali, frugare in ogni buco
che permettesse d’accedere facilmente
anche all’ego più chiuso e riottoso;
ma occorreva certo mantenere
con giudizio e guardinga prudenza
una giusta distanza del piacere
dalla micidiale gelosia,
affinché ogni più piccola e subdola
molesta emozione individuale
fosse localizzata per tempo
e una ferita che ancora gemesse
per la vecchia gelosia (dovuta
soltanto al nostro sangue animalesco)
fosse subito curata e scattivata
con la pietra filosofale della Ragione.
Vissi giorni e notti esaltanti
divorato dalla febbre divina
della grande creazione delle terre
e delle acque; la mente si nutriva
soltanto dell’idea inebriante
d’essere il primissimo stuolo
di future innumerevoli generazioni
per mia mano finalmente liberate
dalle loro dolorose passioni;
poi il settimo giorno
mi soffermai a contemplare anch’io
l’opera perfetta partorita
dalla forza della mente sacrilega,
la mia creatura dalle cento teste
e cento sessi, le cui lingue ingorde
io già lungimiravo congiunte.
Oggi non so più con certezza
se davvero tutto questo fu il motore
del mio esaltante progetto eversivo;
il mio alibi comunque era perfetto,
come i nobili ideali con cui io
confusi con abile dialettica
non solo il Male ed il Bene
ma ogni altro sospettabile sentimento.
Fu comunque così, che riuscii
a risvegliare gli spenti appetiti
del mio Vecchio vegetante senza gloria
nel sepolcro della noia quotidiana;
illuminato dalla Grazia della Ragione,
adesso il buon Priapo era pronto
ad entrare nel grande palcoscenico
per deliziarsi con vere e reali
incantevoli sorelle baccanti.
Si dette finalmente inizio
alle libere danze, dapprima
mascherate da eleganti rituali
e cortesi tentativi di approccio,
seppure vogliosi e impazienti
di mangiare con gli occhi le nudità
ancora gelosamente coperte:
frenava una sorta di prudenza,
quasi fossero nudità di alieni,
cose belle d’altri mondi che soltanto
per caso eran fatte di carne
liscia e bianca che occhieggiava dalle vesti,
e si temesse di urtarne le anime
richiamandole brutalmente alla luce;
ma esse ammiccavano sorridendo
con la leggiadra lascivia animalesca
propria delle femmine terrestri
a chi suasivamente insinuava
i suoi avidi palpi fra le vesti;
e allora s’aprivano gli scrigni
della lussuria, il sangue mugolava
e gonfiava impetuoso le vene
traendone deliziosi sospiri.
Ora i corpi strisciavano sui corpi
coi fiati e le lingue pelose
lasciando sui teneri seni
lunghe scie libidinose di bava;
ma avevano ancora un sembiante
umano, assaggiavano con garbo
le nudità palpando minuziosamente
gl’involucri corposi delle femmine
per penetrare agilmente negli anfratti
ed esplorare le pieghe misteriose
dell’Io, che alzava i suoi occhi
storditi dagli aliti caldi
e dai suoni di parole roventi
dette all’orecchio in un soffio;
e non vedeva certo la maschera
indossata all’occasione dalla Morte.
Ma io gettai subito in pasto
a quella turba le bellezze ancora intatte
della mia donna tanto amata un giorno
ed ora un po’ confusa dalle luci,
io per primo congiungendomi con lei
studiatamente in belle pose sofisticate
per aprire le danze come s’usa
fra educati padroni di casa;
fu con zelo e cortesia esemplari
che come un bell’oggetto dato in prestito
dopo di me la feci lungamente
possedere da membri eccezionali,
che stavolta però erano veri,
di carne dura vagamente sgradevole
e con i brutti grifi imbestialiti
dal premere potente e inarrestabile
del triste sperma che cercava le stelle.
Così successe infine che la mite
infelice vagina a me più cara
si perdesse nella nebbia dell’estasi
mentre io ne studiavo con la lente
e tutti gli apparecchi della ragione
l’anatomia e la fisiologia
nel momento in cui era crudelmente
dilatata da un priapo superdotato
e l’addentava l’orca dello spasimo.
Ero il freddo entomologo che osserva
la solitaria agonia d’una farfalla
mentre sta consumando la sua vita
nel triste godimento d’un giorno.
A quella folla ignuda di impazienti
ansimanti soldati di ventura
pullulante di cosce lingue sessi
impudicamente eretti
avevo dato il segnale della mattanza,
ed ora i manzi scannavano le manze
furiosamente con fatale determinazione
in un grande sacrifizio agli dei
più osceni e indemoniati dell’Olimpo.
Io ne esaminavo i sessi,
affondavo le mani in vagine
ancora calde e frementi di piacere
per trarne nuova forza e auspici
ed infocare il mio priapo perverso.
Ma lungi da essere asettiche
statuine, figure raffinate
di coiti estetizzanti, di giochi
per la conquista di pegni d’amore
eseguiti cavallerescamente
da menti oneste in leali tornei,
m’impaurì la cieca e furiosa
cupidigia di usare il ghiotto corpo
di persone come fossero cose,
ciechi buchi da cui solo succhiare
tutti gli organi vitali per sboccare
nell’oceano solitario e terribile
del proprio egoistico deliquio
come meta, traguardo, unico scopo,
uno sforzo disperato per liberarsi
dal vile sperma e perdersi per sempre
nel mai scordato liquido embrionale,
e poi gettare alle ortiche le spoglie
raggrinzite ed inutili dei compagni.
Non erano agonie di farfalla
con l’anima ferita da bruti
gli osceni scotimenti del bel corpo
della femmina che m’era più cara,
ma reazioni di visceri corrotti,
paurosi chimismi ancestrali
che ribollivano in un corpo ormai sfuggito
alla mia e alla sua debole volontà.
Per errore fatale di calcolo
quel ventre di reattore impazzito
avvampava d’un fuoco maligno
sottratto a ogni controllo di scienza
e di ragione, ogni fessura dilatata
sputava in cielo cenere e lapilli
ed esplosioni contaminanti di orgasmi.
La schifosa tradiva ogni patto
con gli stessi indicibili fremiti,
gli stessi sconvolgenti sospiri
che m’erano così familiari
nel segreto delle nostre notti
e che m’erano cresciuti nel cuore
come pegno e dono del suo amore,
garanzia d’irrevocabile Eden
e d’una vita santamente felice;
e ora impudicamente s’abbandonava
fra le braccia di vacui fantasmi
solo armati di peni insolenti,
lasciava umiliare e lordare
il ricettacolo che m’apparteneva
con sozze eiaculazioni di montoni,
forse in cuore nutriva perfino
piccole eruzioni dell’anima
che potevano essere embrionali
emozioni adulterine, forse anche
vero amore, sì, quella puttana
consentiva a uno sciame di botoli
di suggerle l’amore a me dovuto,
lasciava imperversare il Demonio
nell’orrendo buco nero ch’era stato
fino allora la mia calda nicchia.
Il meccanismo semplice e automatico
onnipotente del sesso era scattato
sfrenatamente con l’antica pervicacia
in quella torma di cani inebriati
dall’odore della cagna in calore;
la aravano e raspavano furiosi
per scavarsi delle tane di lupo
dove prima stava solo la memoria
gentile d’un amore irripetibile;
ora esso flaccido pendeva
da un’enfiata vagina espropriata,
come lingua dolente di rospo
ucciso brutalmente dai barbari.
Quell’orda di sciacalli miserabili
avventati sull’osso erano dunque
quel mitico amore universale
fantasticato dalla mia dottrina
e inseguito come Fata Morgana
per i mari e i deserti della vita?
La Città degli Eroi era svanita
per mostrare solo nani orrendi
che con enormi peni muscolosi
scavavano come pali fra le cosce
nella vulva pelosa del Demonio:
una storpia umanità petulante
esalante umori ferini
che andava sempre più rotolandosi
nella foia misteriosa del mondo;
la quale non ha capo né coda
né un nobile disegno che l’assolva,
ma è solo un brulichio di serpi
svegliate da un raggio di sole.
Quella pozza di magma ribolliva
soltanto di copule e orgasmi
e sordidi intrecci animaleschi;
mai accadde che uno sguardo amico
illuminasse i musi duri e aguzzi
intenti ai loro tristi bisogni;
il mio esaltante anelito evangelico
si trovava isolato in mezzo a un branco
di torve creature che certo
mai più potevo amare, anzi odiavo
come quelli che rubano il pane
alle bocche sbigottite di affamati.
Da allora io usai ogni forza,
ogni mezzo e ogni trama possibile
per riprendermi quel corpo di femmina
forse ancora caldo e gentile
che credevo appartenermi di diritto,
o per sottrarre allo scempio almeno l’anima,
ch’era stata il mio agnello sacrificale
e che volevo ancora immaginare
gemente e piangente, rifugiata
nell’ultimo anfratto ancora integro
del suo io lacerato e calpestato.
Ma fieri maschi accorrevano d’ogni parte
come muta di cani imbestialiti
all’odore della vulva in calore
per ficcarvi il loro muso estasiato;
più nulla poteva allontanare
quelle mosche carnarie petulanti
da quel culo, quella fica, quegli occhi,
agitati dalla folle danzatrice
scagliata come lugubre falena
contro il fuoco accecante di Dio
per lasciarsi finalmente bruciare.
S'accendevano risse furiose
fra iene e sciacalli affamati,
ove ancora il mio Vecchio spelacchiato
stava in mezzo incapace di ringhiare
e perdendo pietosamente il suo pelo
contro zanne e corazze soverchianti
di più giovani e sprezzanti rinoceronti.
Aveva le ali tarpate
anche dalle ingiurie che ella
così barbaramente gl’infliggeva
rifiutandogli anche il conforto
tanto necessario del suo ventre,
ed ogni volta doveva rivivere
l’antica crudele cacciata
piena di vergogna dall’Eden,
ch’era stato una volta il caldo grembo
seppure ingeneroso della madre.
Ma essere scacciato dalla fonte
d’ogni bene mi fece riscoppiare
per un vizio perverso dei sensi
una polla di rabbia incontenibile
ed anche gagliarde e insospettate
velleità d’aggressioni e di stupri
che per magia rianimarono il Vecchio
in quella sordida lotta per la vita.
Fu proprio una beffa bizzarra
a prendersi gioco del mio membro
indifeso come un verme: quanto più
il nodo sotterraneo e invincibile
di nervi ed odio impediva a quella femmina
di godere anche solo per poco
delle mie umili gentili erezioni
e accogliere con gli altri anche il mio seme
in quel pozzo posseduto da tutti,
tanto più cocciuto ed audace
il mio sesso scattava inalberandosi
come povera cornacchia impagliata
in un furore di slanci sfortunati.
Rialzando il capino disperato,
riuscì qualche volta anche a competere
per la suprema sopravvivenza dei suoi geni
con quelle bestie dai rostri inesorabili,
e piangente ancora a mischiare
nella turpe vagina stracolma
il suo seme senza alcuna vergogna
con quello dei rozzi fantasmi
senza volto né nome né gloria
che facevano ressa alla sua porta.
Erano gli ultimi singhiozzi,
i colpi di coda d’un pene
ormai decapitato e in agonia
poco prima di giacere senz’ali,
e per sempre, nel silenzio sepolcrale
che ricopre le città abbandonate.
Ma i maramaldi continuavano a colpire
con le daghe potenti dei priapi
strappando ad un uomo già morto
anche gli ultimi ricordi sanguinanti
sopravvissuti alla fine del suo amore.
Ella ormai non era niente più
che un vuoto castello espugnato
da brutali arroganti guerrieri
che violato ogni tesoro di virtù
trascinavano disgraziate prigioniere
a rotolarsi come tristi bagasce
nel fetore di bordelli levantini.
Là imparò l’abitudine al male,
alla menzogna, al sotterfugio diabolico
per ingannare ragione e sentimenti;
e senza freni su giacigli proibiti
soddisfece l’imperiosa libidine
che non era più capace di frenare,
quella ch’io con la mia folle istigazione
le avevo inoculato nelle vene
e che ora spandeva dovunque
il fetore della corruzione.
Continuai a mendicare un po’ d’amore
da quel corpo di baldracca riluttante,
ora estorcendo negli attimi di sosta
qualche effimero coito meccanico,
ed ora montandola bestialmente
reso folle dal rifiuto, sperando
con lo stupro che alfine le scattasse
il guasto meccanismo del piacere
e potere per l’ultima volta
udire dei guaiti di gratitudine.
Ma invano ne piegavo la carne
e la caparbia volontà per prolungare
il sogno di restare aggrappato
alla sua poppa ed ancora succhiare
l’acido latte del suo rapido disfacimento,
per credere di non essere stato
ancora del tutto scacciato,
per esistere ancora almeno un poco;
ma anche soltanto per morire
alla sua ombra, illudermi che ancora
non fosse del tutto corrotta;
per restare ad adorarla in ginocchio.
Mi sarei anche solo appagato
di vedere una piccola emozione,
uno sguardo benevolo, un sorriso
che non si nega al più sudicio dei cani
mendicanti nella chiesa scellerata
dove ella era dea, forse infelice,
ma in cui regnava su uomini e cani
nutrendoli con liberale munificenza
con la droga che stillava dai suoi occhi
e poi punendoli a suo piacere e arbitrio
mungendo a morte i loro peni vuoti
e risputando le ossa indigeste
nella fogna donde erano usciti.
Ella sempre più caparbiamente
mi sfuggì per vicoli oscuri
con l’inganno, il sotterfugio, l’arroganza,
nascondendosi in luride stamberghe
a sfogare inconfessabili lussurie;
ed io sempre col pianto negli occhi
ad inseguire quel mio laido tormento
per le strade, i vicoli, le calli,
ogni volta irrompendo come il vento
dai pertugi adulterini delle case
nei letti ancora caldi di libidine,
sempre credendo di riprenderne l’anima,
sempre stringendo nelle mani un corpo vuoto,
sempre trapassando furiosamente
col pene inappagato solo un’ombra.
Tristi persecuzioni e tristi fughe
di tristi anime che un giorno fatidico
della loro così onesta primavera
s’erano gioiosamente trovate
pur nel buio dubbioso della terra
così che tutta quanta n’ebbe luce,
ed ora s’addentavano e scarnivano
con una cupa, ostinata, rabbiosa
voluttà di uccidere e morire,
mille volte sopraffatte dall’ira
e mille volte da un fugace perdono,
e poi di nuovo assediate dai dèmoni
in un urlo di notti devastate
da agguati, schiaffi, pianti, inseguimenti
e umilianti contrattazioni di sentimenti
che affondavano nella carne del cuore
tutti i denti delle loro vergogne.
Insonne come l’alba che precede
l’ultimo supplizio capitale
è la notte degli amanti prigionieri
dei giochi più perversi della ragione,
e che pure si dibattono ancora
sperando di vedere la luce.
Ero ormai solo stanco spettatore
di sordide penose altrui commedie,
tresche, amori, passioni animalesche,
altre menti sprofondate nel buio
e cadute come teste tagliate
dalle spade della grande cacciatrice.
Ormai per me, più né in cielo né in terra
né in altri luoghi dello squallido universo
c’era una speranza di pace:
ero un tragico errore dell’evoluzione,
un mostruoso fungo mutante
della lussuria, e finalmente m’arrendevo
alla speranza d’una morte pietosa.
Che cosa mai potevo più temere
dalla morte, se la vita stessa
con la sua piccola speranza d’amore
era ormai soffocata dal Male?
Sempre più superba e infelice,
tracotante e disperata,
la sua bellezza continuò a ferire
ovunque intorno come un faro nella notte
seminando mille piaghe mortali
con la lama accecante del suo sesso.
Anche lei era ormai mortalmente
intrappolata in una via senza ritorno,
consumata dai suoi stessi ingranaggi
senza fine; ogni nuovo mattino
che nasceva luminoso nel mondo
la coglieva sempre più smarrita
nei febbrili tentativi di lavare
via dal corpo le sozze secrezioni
dei cadaveri appena divorati,
i resti dei posseduti rinoceronti
decapitati nel suo letto dalle lugubri
ormai stanche tenaglie di mantide.
Fece un gran solco nel cielo,
come un astro di gloriosa bellezza
che tramonta su un popolo di idolatri,
grigie ombre che ancora la invocano
dal carcere della vita quotidiana;
fu una scia che abbacinò la memoria,
ed ora ch’è tornato il buio
non c’è più niente di degno da ricordare.
Ma l’utero sciagurato di sua madre
non l’aveva partorita con dolore
per dispensare luce ed amore,
humus di pace laboriosa
agli uomini di buona volontà;
ella solo rovello ed angoscia
e inestinguibili roghi della ragione
seminò in chi poté avvicinarla
pur senza mai riuscire a penetrarne
le mura gelose dell’anima,
e allora cercò di possederne
con un fugace amore sfortunato
almeno il bellissimo corpo.
Il cadavere del mio ego
fu il primo a scivolare nel buio;
era il più fragile e ignudo
e per un lasso interminabile di tempo
che la memoria ha voluto cancellare
cercò di guarirsi le piaghe
rotolandosi per mari e per monti
con la mente ottenebrata dal tremito
di una lunga, lancinante, squassante,
rabbiosamente tormentata dai lupi
e mai veramente finita
notte d’astinenza,
in cui nessuno poteva soccorrerlo
con una piccola dose di droga.
Pietà per quella figlia di Dio,
quell’essere infelice, la bambina
che non aveva imparato a riconoscere
il male del mondo che ci assedia,
e infine in quelle tenere viscere
io avevo introdotto il Demonio
che col tarlo devastante del suo priapo
ne ha fatto la cloaca del Male.
O forse era falena destinata
a soccombere sul lume d’una lampada
trascinando con sé negli abissi
del suo infausto furore uterino
il miserabile mondo dei maschi
con la macina legata al collo
del suo stesso desiderio di morire?
Non si seppe più nulla.
Fu inghiottita dal vento nero e forte,
sovrano degli oceani e dei deserti
che ella, come un bianco affaticato
uccello migratore con le ali
rese troppo pesanti dalla pena
di un’antica ferita verginale,
di letto in letto disperatamente
e con l’anima ormai senza forze
aveva invano tentato di valicare
per andare a morire lontano
sulle spiagge di isole dimenticate
dove vanno a morire gli uccelli
nel sentore della fine, con nel cuore
il tormento inappagato d’una vita.
Io mi chiusi in una tana d’animale
nel buio intestinale dei pensieri
a patire privo d’occhi e d’udito
il travaglio d’una lunga metamorfosi
contendendo palmo a palmo il terreno
all’avanzata di un’eclissi della mente;
ma questa sempre più s'inabissava
in un oceano minaccioso di sargassi
come un grande bastimento alto di vele
di cui si vede soltanto la prua
sporgere ancora in un subbuglio d’acqua.
In quella grotta io feci la mia cuccia
per un sonno agitato dai fantasmi,
e fu il lungo letargo di un orso
che attende nell’inedia lo spiraglio
d’una troppo lontana primavera.
I fantasmi che popolano le notti
ebbero possesso del mio corpo;
per un tempo che mi parve interminabile
le ombre continuarono ostinate
a sgusciare inafferrabili fra i pensieri,
a fendere la carne dell’anima,
a masticarla con denti taglienti
finché l’ultimo organo senziente
fu dissolto; solo allora finalmente
un pietoso misterioso torpore
con l’aspetto quasi umano di sonno
poté chiudere gli occhi della memoria.
Ma non era che la fosca avvisaglia
d’un nuovo insidiosissimo male
che la Natura m’incubava nel ventre
dove aveva già deposto le uova
mortifere della mia colpa.
Del buio di quella grotta
ho soltanto ricordi evanescenti,
ceneri di grovigli inestricabili,
scorie d’una pena pesantissima
che intorbidano ancora la memoria:
un’umile figura di madre
che accudiva ai miei bisogni corporali
e un raggio che filtrava inosservato
da un pertugio superstite delle imposte
portando da un mondo lontano
che continuava rumorosamente a vivere
curiose indecifrabili ombre
schiacciate pigramente sul muro
che s’agitavano subdole e lente
prigioniere nella camera oscura
come pesci in un acquario di vetro;
suoni indistinti di quel mondo,
grida silenziose, bolle d’aria
come piccoli feti uno ad uno
partoriti da un enorme pesce,
s’aprivano la strada faticosamente
per arrivare al mio cuore in letargo,
e sembravano voci di bambini
o forse davvero lo erano
che giocassero magici giochi
sul marciapiede assolato della strada.
Anche quando riebbi le forze
per varcare tanto abisso di ombre
risalendo montagne d’oceani
come un piccolo ostinato veliero
che cerca il rifugio d’un porto,
ero un dolorante sopravvissuto
al cieco olocausto di sesso
ch’è il tetro carnaio del mondo;
ma almeno mi lasciavo riavvolgere
dalla poppa della casa natale,
il generoso uovo embrionale
da cui tutto per miracolo nasce
e a cui tutto per miracolo ritorna;
anche il mio vecchio cane
risorgendo dal suo lungo sonno
era accorso guaendo da lontano
a scaldarmi col fiato le mani.
Il mio ciclo corporale era compiuto;
avevo pagato il mio debito
al groviglio di copule e passioni
cui siamo impietosamente condannati
con lo scopo occulto di propagare
un’inutile specie animalesca
atta solo a ricoprire d’escrementi
un pianeta sconosciuto dell’universo;
avevo partorito con dolore
il mio seme disperdendolo nel mondo,
ed ora come esausta cicala
spremuta dall’estasi tirannica
della fregola dovevo rassegnarmi
ad uscire dal mondo in silenzio.
Ma no, io non ero quell’inetta
cicala con il sesso sgonfio:
io potevo ancora risorgere,
compiere la suprema metamorfosi
che dalla larva attinge gli splendori
dell’insetto perfetto, le vette
di un ciclo biologico ispirato
ad un vero evangelico Amore;
io potevo finalmente abbandonarmi
ad un fiume di nobili emozioni
scalando le montagne del Sublime,
poi che ora ero un uomo asessuato,
non montone fra i montoni d’un gregge
condannato ad annusare ogni fremito
delle vulve di pecore in calore;
ero pronto a dar tutto me stesso
a un eroico progetto dello spirito,
l’unico capace di squarciare
i veli del cielo e della terra
e lasciarci contemplare anche solo
per un istante la perfezione dell’Essere
e delle fulgide creature ultraterrene.
Cominciavo a intravedere le vette
illuminate dalla luce di Dio;
là era certo occultata dalle nebbie
anche la Terra Promessa,
l’Eden che ci avevano tolto,
abitato dai Sapienti della terra
e dai limpidi cuori dei giusti
in pace con i sensi e con gli uomini;
già vedevo le navi del deserto
che approdavano ai giardini delle oasi
dopo lungo favoloso cammino,
le fresche verdeggianti foreste,
le buone piante, i mansueti animali,
tutto come prima dell’avvento
rovinoso del Peccato; nel mezzo
c’era il nobile albero della Conoscenza,
tuttora vagheggiato con dolore
dalle anime monche dei mortali
buoni e cattivi, ogni giorno più smarriti,
crocifissi alle loro passioni;
confidavo di coglierne i frutti
non più proibiti e con la nuova sapienza
superare gli ultimi gradini
che separavano la mia anima dal Bene.
Ancora non avevo realizzato
che anche fra le pieghe dei bei corpi
quando sembrano donarci il piacere
c’è il virus della Morte Rossa
lesto a impossessarsi degli uomini
che si pervertono, lesto ad infierire
con le torpide ferite del suo dente
e mai sazio di nutrirsi di noi:
un assassino incapace di perdono
perché lui stesso parassita condannato
a propagare nelle nostre viscere
i suoi figli voracissimi; col fiuto
conosceva già tutte le mie colpe
anche se si erano nascoste
per la vergogna, e quando m’ebbe unto
non ebbi scudo, angelo, Dio,
che potesse salvarmi dal male.
Eppure a prima vista mi pareva
soltanto la modesta infezione
d’un mostriciattolo di microbo innocuo
dimenticato da un untore bislacco:
un ridicolo pidocchio disperato,
o lo scherzo d’un dio sghignazzante,
insomma solo un povero diavolo
dalla vita animalesca che lottava
per una grama ingrata esistenza.
Ma ora se ne stava proprio lì
col suo brutto pungiglione confitto
nell’occhio stupito del mio pene,
cui certo era rimasto attaccato
coi denti come infame mignatta
dal negro tempo della mia vergogna
quando i sessi pompavano come stantuffi
scambiandosi in delirio l’un con l’altro
seme e sangue, sangue e morte: un vero agguato
senza scampo per il pene incauto
che s’avventura dentro tane sconosciute.
Quando infine m’accorsi che il pidocchio
m’affondava i suoi denti nelle viscere,
era ormai diventato un grosso rospo
ingombrante e arrogante che ingrassava
gozzovigliando dentro il sacco del mio corpo:
un enorme schifoso parassita
che succhiava dal mio cuore tutti i palpiti
del grande Amore cui mi stavo abbandonando
con la letizia e la speranza d’esser caro
ancora a Dio. Io invece questo Dio
non l’avrei mai più conosciuto,
il cuore mi si stava sgonfiando
come punto da un serpe e già ne usciva
un sibilo di gas maleodorante,
presagio di un male irrevocabile
destinato fatalmente a compiersi.
Il Nemico non mollò mai più la presa
di tutte le sue unghie sul mio corpo;
m’inoculava sempre più il veleno
mentre incredulo osservavo l’invasione
e credevo che fossero foruncoli,
sfoghi degli umori corporali
forse ancora così densi e spessi
da rendere il mio mistico anelito
un po' troppo vischioso, quindi lento
ad uscire dal ventre animalesco
per essere degno di Dio,
ma che un giorno sarebbero evaporati
soltanto alla vista dell’immenso
divino Serbatoio di luce
che fa vibrare tutto l’universo.
Invece l’eruzione del male
corruppe tutto il corpo e quando infine
venne meno il necessario nutrimento
anche alle radici dello spirito
cominciarono a colare da ogni poro
i liquami di colei che con orgoglio
avevo un giorno chiamato “la mia anima”.
Quell’anima ancora per molto
lottò, oh sì, come lottò,
per rientrare nell’ordine dell’universo;
ma neppure tutto il pianto del mondo
poté rimuovere il veleno del disordine
che la triste creatura mortale
aveva opposto brutalmente a Dio
con la sua cieca perversa volontà
lacerando con insane promiscuità
tutti i veli di pudore che proteggono
la santità delle mucose sessuali
dalla cupa bestialità degli uomini;
avevo irriso la sapienza del mondo,
che protegge nei giusti canali
solo la fusione di due esseri
che s’amano e in un lampo di grazia
gli concede in un’estasi abbacinante
per un istante di avere esperienza
dell’arresto del tempo, del silenzio,
del perdere l’identità individuale
e guadagnare l’Assoluto di Dio.
Il quale certamente deve esistere
vero e forte e al di fuori di noi
ed anche in una forma accessibile
se si compiace d’entrare in questi corpi
incapaci altrimenti di vederlo
anche per il buco del sesso,
se si lascia intravedere per un attimo
nell’urlo d’un orgasmo che prorompe
da un luogo sconosciuto dell’anima
che da sempre lo invoca disperata,
in cui di colpo svanisce ogni fallace
categoria corporale e si accende
come un sole anche la piccola luce,
così indegna, dello spirito ch’è in noi.
Ma io dalla buia e delirante
suburra del mio ego m’ero eletto
a demiurgo, legislatore, dio,
con azioni pervertitrici di ordine;
e ora l’Ordine dell’universo mi rifiutava
come un osso immasticabile, una scheggia
nei Suoi ingranaggi; l’acido potente
delle Sue lacrime scioglieva le mie ossa
per rimuovere il molesto corpo estraneo
dall’occhio ferito di Dio.
Per un tempo crudelmente lungo
quanto il sordido budello del Maligno
che m’aveva ingoiato anima e corpo,
ho vomitato coi catarri del male
anche le parti più gelose della mente
indispensabili alla vita dello spirito;
che ora sempre più mi s’intorbida,
cade in lunghi sopori letargici
interrotti da scosse di morte
contro cui è ormai vano lottare:
l’involucro misterioso dell’Io,
trafitto dal ripudio insostenibile
di Dio, raggrinzisce come un fungo
seccato dalla sete e dal vento.
Forse alla fine del mio tunnel
m’attende il varco angusto del perdono?
questa nera, lunga, convulsa,
oscena irrefrenabile emorragia
di pensieri e ricordi disfatti,
di brandelli di anima che invocano
pietà, basterà a liberarmi
d’ogni colpa, a spogliarmi per sempre
d’ogni crosta bestiale di materia?
dopo tante offese all’Amore,
vorrà questo Dio sconosciuto
che m’ha amato quand’ero bambino
trarre ancora a Sé la mia anima
come prima della nascita,
come madre che tutto perdona,
nel mare primigenio del Suo grembo?
Ma forse non è ancora tempo:
un armistizio, una piccola ricchezza
di pensiero forse m’è concessa,
una piccola pagina della mente
in cui leggere ancora dei ricordi,
rintracciare le semplici emozioni
di giovinetto; forse anche il tempo
per un breve avaro abbandono
alle pur ingannevoli seduzioni
dell’aria e dei fiori, che ora
stanno dolcemente chiudendosi
per lasciare luogo alla notte
con la fioca illusione che domani
possa esserci ancora un mattino
coi profumi eterni della terra
portati dal vento; oh questo soffio
così tenero e impuro del vento
che si chiama primavera, che sempre
ritorna instancabile e amorosa
a trafiggere gli esseri viventi
in un ultimo subbuglio di sensi!
Forse non sono che fantasmi
questi odori così grati che sembrano
portati dalla brezza della sera
da continenti purtroppo inabissati
della mia ormai morente memoria;
ma entrano gioiosi dalla finestra,
vincono le difese delle cortine,
riaffiorano freschi come polle
in quest’ultima arida spiaggia
dove il vento della vita è già placato
e in cui mi scopro ad aspirare forte
come un cane dubbioso ancora l’aria
per ricordare l’odore del padrone.
Oh, dolce Amica che m’avevi avvinto,
ma di te non ho saputo trattenere
che la poca memoria materiale
dei profumi respirati in giorni e notti
ricamate di effimere dolcezze,
per cui oggi ancora mi struggo
mentre sto per smarrirmi nel Nulla.
Ora so che si comincia a morire
già da molto lontano:
è quando si comincia a morire
nei cuori che abbiamo ferito
anche senza volerlo.
Ma con voli sfortunati di Icari
tutti tentano sempre la luce
dei soli più abbaglianti e lontani
che non è consentito guardare,
e sempre li perde nell’oceano
il peso troppo amato del corpo,
di cui ora non sanno che farsi.
Ecco che ancora una volta
quel peso mortale ci ha vinti
prima d’essere riusciti ad intendere
il vero significato dell’Essere
che sottende questa vita corporale
di cellule e chimismi indecifrabili;
qualcuno ci serra in silenzio
alla gola per prenderci l’anima.
Ancora pochi giri di soli
e poi dovrò lasciarmi espropriare;
non si potranno possedere ricordi
né esprimere parole significanti
per lasciare di me almeno un lembo
che conservi sembianze ancora umane,
un messaggio d’addio che commuova;
ora l’inclemente stagione
dei terribili amori con la Morte
s’appresta a tormentarmi di sogni,
queste insane intriganti creature
che nascono dal buio del mondo
e baciano e accarezzano gli uomini
poco prima di coprire il loro corpo
di repellenti secrezioni, e poi d’oblio.
Forse questo Io straordinario
che patisce senza lacrime l’attesa
come uccello intrappolato per caso
nel tubo senza fine della morte
non è stato nient’altro che un sogno,
un’irreale bizzarra creatura
disegnatasi da sé in una mente
senza tempo né luogo come quella
che sogna, soltanto ideata
ma mai da nessuno realizzata,
con le cieche finestre dei sensi
affacciate su un buio cortile.
In questo nero sogno disperato
non si vede alcun posto per Dio;
forse è la prova evidente
che ci ha abbandonati,
o non esiste.
Ma chi altri, che non sia la Madre,
sta per chiudere quelle finestre?
M’hanno detto che quando è il momento
è difficile emettere suoni
che siano articolati e comprensibili
o almeno dignitosi e composti;
è concesso di raccogliere un ricordo
dall’oceano ch’è dentro di noi
se si riesce ad afferrare con un gancio
un’isola ancora integra della memoria,
se è possibile distinguerla nel buio;
ma più spesso sono vortici notturni
d’un grande sogno con miriadi di sogni
chiusi uno dentro l’altro ermeticamente
come vuote sorridenti matrioske.
Finché qualcuno non viene un mattino
a chiudere silenziosamente
anche quelle buie finestre. |